
A tale for the rootless
Teresa Noronha Feio, vincitrice del bando Permutazioni 2019/2020, ci racconta il suo progetto A tale for the rootless.

Teresa Noronha Feio, vincitrice del bando Permutazioni 2019/2020, ci racconta il suo progetto A tale for the rootless.

La condizione di emergenza in cui stiamo vivendo da un anno ha destrutturato qualsiasi progettualità e certezza. Ci siamo ritrovati nudi: artisti, operatori, cittadini, con un sistema di relazioni e di competenze da riscoprire, per far fronte al presente e immaginare il futuro delle nostre istituzioni. Nel corso di questi mesi abbiamo ritrovato la necessità di valori originari e abilità quali le capacità di ascolto, di collaborazione e di mettere a sistema le nostre competenze per far fronte ad un obbiettivo comune. Tutte capacità e valori certamente già presenti prima del Covid ma non più interpellate per la sopravvivenza del sistema e, quindi, non ancora fondamentali.
In questo contesto l’istituzione culturale di oggi manifesta alcuni aspetti che possono distinguerla dal modello di istituzione culturale tradizionale ereditato dal pensiero illuminista e che, finalmente, le consentono di rappresentare la contemporaneità. Una sfida importante che ci attendeva da tempo e che svela un modello di istituzione culturale o artistica che può essere accessibile, plurale, dinamico, impegnato, visionario, capace di rappresentare una pluralità di voci, di accogliere il presente e di fare sistema per dare risposte alle esigenze della propria comunità di riferimento:
Per acquisire questa porosità e capacità reattiva, l’istituzione ha però bisogno di coinvolgere attivamente tutta la sua struttura organizzativa e il suo sistema di riferimento, facendo appello sia al senso etico di ciascun individuo che la attraversa nell’affrontare la relazione di gruppo (partner, beneficiari, policy maker, fornitori), sia alle sue soft skill, che dobbiamo integrare per poter rispondere alle istanze di contesto interno e esterno all’istituzione. Una logica questa che, sostenendo il valore del singolo e delle sue abilità nel processo di costruzione dell’identità dell’istituzione, suggerisce un ribaltamento di prospettiva delle sue dinamiche di sviluppo. Il singolo, la persona con le sue abilità e la sua sensibilità, influenza lo sviluppo dell’istituzione culturale e chissà se questo approccio non potrà contribuire allo sviluppo di un processo culturale di umanizzazione delle istituzioni contemporanee in cui l’elemento della fragilità e quello della diversità possano essere accolti, integrati e valorizzati.
Come possono l’arte e la cultura, in quanto patrimonio vivente, curato e sostenuto dalle istituzioni culturali, partecipare e contribuire attivamente allo svelamento del profilo di un nuovo modello di istituzione culturale? L’arte, in quanto spazio privo di giudizio, dedito all’osservazione, all’accoglienza, all’esplorazione del vivente, ha una capacità incontestabile di cogliere il potenziale inespresso, nascosto della società contemporanea, di coglierne la poesia e di esplicitarla, creando uno spazio di riflessione individuale o collettivo. Questo, oggi, è più che mai possibile anche grazie ai processi di audience engagement, che hanno consentito lo sviluppo di dispositivi artistici di relazione col contesto, messi a punto dagli artisti recentemente riscoperti per rispondere all’esigenza delle istituzioni di prendersi cura della domanda di cultura. In questi termini l’arte e la cultura rappresentano per l’istituzione sia lo strumento ideale per leggere il proprio contesto di riferimento con la giusta attenzione, poiché estraneo al pre-giudizio e sensibile al potenziale individuale/collettivo, sia lo spazio possibile per condividere la conoscenza prodotta dall’esperienza sul campo in forma collettiva con un contesto più ampio di quello che l’ha generata. Con queste premesse circa la necessità di integrare l’arte come strumento di rinnovamento e di ridefinizione del senso delle istituzioni culturali per il proprio contesto di riferimento, è possibile ridisegnare il rapporto tra gli artisti e le istituzioni? Intorno al desiderio comune di cogliere o svelare il potenziale, sulla capacità di immaginare il futuro, può costruirsi una nuova alleanza tra artisti e istituzioni?
Nel corso degli anni, da Centro di Residenza a Casa Europea della Danza, la Lavanderia a Vapore, direttamente o indirettamente, si è costantemente misurata con questi interrogativi e ha creato uno scambio costante con alcuni artisti intorno alla visione dell’arte e della cultura e al senso di un luogo di cultura per il proprio contesto che ha poi preso forma in progettualità condivise nel corso della stagione o in veri e propri percorsi di ricerca intorno ai dispositivi artistici di relazione con il contesto.
Nato nel 2017 come gruppo di lavoro per rispondere a esigenze concrete legate a spazi e calendari, nel dicembre 2020 il TRA – Tavolo della Ricerca Artistica diventa una nuova realtà artistica composta da più di venti artisti e formatori del territorio piemontese che da anni lavorano, ciascuno con le proprie specificità, all’interno del variegato settore della danza contemporanea: Amina Amici/Zerogrammi, Barbara Altissimo, Elena Cavallo, Fabio Castello, Francesca Cinalli/Tecnologia Filosofica, Gabriella Cerritelli, Francesca Cola, Renato Cravero/Tecnologia Filosofica, Doriana Crema, Erika Di Crescenzo, Francesco Dalmasso, Claudia Adragna, Elisa D’Amico, Cristina Da Ponte, Teresa Noronha Feio/Shared Training Torino, Emanuele Enria, Teresa Noronha Feio, Debora Giordi/BTT, Riccardo Maffiotti/Tecnologia Filosofica, Daniele Ninarello, Elena Pugliese, Aldo Rendina/Tardito Rendina, Said El Moumen, Samuel Fusca’, Federica Tardito/Tardito Rendina, Raffaella Tomellini, Aldo Torta/Tecnologia Filosofica, Antonella Usai/NAD.
In questo tempo pandemico, all’interno del tavolo, sono nati dei sottogruppi di lavoro con l’obiettivo di esplorare ogni contesto culturale con cui la Lavanderia ha aperto un dialogo: la scuola, le imprese, i luoghi di cura e di benessere. Ogni gruppo di lavoro ha riconosciuto un proprio referente di area di ricerca, che ha la funzione di curare il dialogo tra l’artista e l’istituzione e di sviluppare un sentiero di ricerca comune, fondato sulla reciprocità di interessi1 di istituzione, artista e contesto specifico. Questa mediazione, fino ad ora, si è rivelata strategica sotto diversi punti di vista: in primis nel costruire un clima di reciproca fiducia, poi nella comprensione delle esigenze reciproche e infine nella costruzione di azioni comunemente riconosciute di valore dall’artista, dall’istituzione e dal contesto sociale specifico. In questi termini la Lavanderia a Vapore è diventata anche uno spazio di co-creazione e progettazione tra istituzioni e artisti che ha coinvolto i cittadini che, a diverso titolo, interpellano azioni su misura ed interventi di cura rispetto ad un preciso contesto culturale.
Proprio grazie a questa cura, nonostante le difficoltà del momento storico, il TRA sta operando rispetto a tre direzioni di ricerca:
Grazie a queste direzioni di ricerca la Lavanderia a Vapore può, quindi, iniziare a sperimentare questa apertura alla società civile insieme agli artisti, per esplorare quelle forme e quei contenuti che le consentono di rappresentare il tempo presente, di uscire dall’incanto di un mondo da coinvolgere, per ritrovarsi in un mondo che non sente e non vede il valore che l’arte può portare all’individuo e alla collettività. A volte a causa della sordità o cecità, a volte per mancanza di suoni o di immagini evocanti. Poco importa. Quello che conta è capire come riattivare questo canale di dialogo per far sì che l’arte e la società possano, nuovamente e spontaneamente, tornare a frequentarsi nel quotidiano.
1 Loro, M. (2020) Oltre l’audience development, in M.Gilli e S. Scamuzzi ( a cura di) Pianificare il turismo. Innovazione, sostenibilità e buone pratiche (pp. 90-98), Carocci, Roma
Mara Loro, Research curator consulente per l’innovazione e la ricerca della Fondazione Piemonte dal Vivo, co-founder Itinerari Paralleli.

Mi chiedo quale sia il posto della danza in questa coreografia attuale e quotidiana: dov’è andata a finire la danza? In questa crisi ci troviamo improvvisamente di fronte alla sfiducia del corpo. Diffidenza dei corpi degli altri e anche dei nostri stessi corpi, le “case” in cui viviamo. Non sappiamo cosa succede dentro di noi e dipendiamo dalle conoscenze di medici, scienziati e politici che ci guidano. Ci preoccupa la vicinanza agli altri, ci preoccupa il tatto, ci preoccupa essere circondati da una comunità, ci preoccupa condividere il respiro. Purtroppo, queste cose – la vicinanza, il tatto, la comunità e il respiro – sono tutte essenziali per il DNA della danza. Questa crisi colpisce non solo la nostra pratica, ma anche chi siamo. La danza è essenzialmente la condivisione di un’esperienza. La danza è comunità.
Quando guardiamo alla parola “coreografia” e al suo significato originale in contesti antichi, capiamo che il “coro” non era solo lo spettatore di una tragedia, ma soprattutto era un commentatore o il gruppo che giudicava in terza persona, da un punto di vista oggettivo, i problemi dei protagonisti. Questo significa che il coro ha una funzione profondamente critica: riesce a vedere attraverso le illusioni dei grandi eroi o dei leader. Penso a quello che possiamo vedere da questo punto di vista in terza persona nel coro, e a quali illusioni vediamo attraverso. Riusciamo a vedere le questioni più pertinenti e fondamentali di questa pandemia che continuano a essere ignorate, cioè il modo in cui siamo arrivati a trattare il nostro corpo e, nella danza, il nostro partner principale, ovvero la terra? Anche se cruciale in questo momento, forse questa coreografia di massa della pandemia ci toglie l’attenzione dalle questioni a lungo termine che abbiamo tra le mani?
Mi chiedo anche, come artista, quali altri approcci possiamo vedere? Dopotutto, la danza è una delle attività più sostenibili, ecologiche ed estetiche che si possano immaginare. Non si esaurisce e non ha necessariamente bisogno di risorse perché è dentro di te e tutti possiamo ballare.
“Essenziale” è diventata una parola quotidiana. Noi intendiamo il cibo e l’aria come essenziali, decidiamo quali negozi sono essenziali. Credo anche che la danza sia essenziale. È stato Nietzsche a dire: “E dovremmo considerare perso ogni giorno in cui non abbiamo ballato almeno una volta”. In “Genealogia della Morale” Nietzsche dice che l’affermazione della vita deve essere realizzata attraverso pratiche corporee che aiutino a far emergere la creatività di cui sono capaci i nostri sensi e la nostra mente. La danza è una pratica corporea. Dice che impegnandoci in pratiche come la danza acquisiamo la consapevolezza sensoriale di cui abbiamo bisogno per essere in grado di discernere se i valori che creiamo all’interno della società, e i movimenti che facciamo nel mondo, sono buoni – per noi stessi, ma anche per la terra. Ecco perché ha detto: “Non so cosa lo spirito di un filosofo possa desiderare maggiormente di essere che un buon danzatore. Perché la danza è il suo ideale, anche la sua arte, infine anche l’unico tipo di pietà che conosce, il suo ‘servizio divino’”.
Domande importanti da porsi al momento sono: come possiamo trovare un modo per continuare a danzare in queste circostanze? E possiamo trovare un modo per aiutare la danza in questi tempi? Mi sono interrogata sull’aspetto curativo della danza. Asclepio, il semidio greco della medicina, era venerato nei templi dell’Asclepio dell’antica Grecia, il più celebre dei quali era l’Asclepio di Epidauro. Questi centri di guarigione includevano nelle loro pratiche medicinali la guarigione spirituale e l’attenzione per uno stile di vita sano, la dieta, il fitness, la musica e il teatro. La salute è molto più dell’assenza della malattia e molto più della medicina. È ciò che mangiamo, è il modo in cui ci prendiamo cura del nostro corpo. Non si tratta solo di guarire il corpo, ma di creare un ambiente sano in cui prosperare. Agli inizi degli anni ’80, una volta ho sentito Meredith Monk parlare del potere curativo dell’arte o dell’arte come antidoto. Lei pensa che la guarigione non stia solo nel canto, nella danza, nello spettacolo, ma anche nella realizzazione dell’arte stessa e questo è un processo di interazione tra ciò che accade all’interno del corpo e ciò che è fuori dal corpo. Alla fine questa interazione tra lo spazio interno ed esterno del corpo è tutta aria, respiro.
Nel 2015 stavo lavorando a un pezzo intitolato ‘My Breathing is my Dancing’. Faceva parte di una ricerca su ciò che potevo considerare la mia danza e da dove potevo generare movimento. Ho pensato al mio respiro come alla mia danza, al mio camminare come alla mia danza e al mio parlare come alla mia danza. Ciò che è importante del respiro – ciò di cui parliamo così tanto in questo periodo – è che è letteralmente e simbolicamente vita. Direi che se la coreografia riguarda la scrittura dello spazio tra le persone, si tratta di come quello spazio esiste grazie al e per il respiro. Questo significa che la coreografia riguarda il modo in cui lo spazio respira.
Considerare il posto della danza nel nostro mondo è importante in questi giorni, non solo in termini di come preservarlo e mantenerlo in movimento attraverso tutte le restrizioni e le cancellazioni ma anche in termini di ciò che possiamo imparare dalla danza, il respiro della danza, la capacità che deve avere di essere autosufficiente, e anche la natura di creare comunità della danza.
Aiutiamoci l’un l’altro, ispiriamoci a vicenda, troviamo un modo per capire come questa situazione sconosciuta possa portare a nuove soluzioni e a nuovi modi di comunicare. E credo che questo richieda la volontà di guardare la bussola interna e verificare con se stessi, cosa succede con se stessi e con se stessi nella relazione con l’altro.
Uno dei grandi problemi è che le regole che ci troviamo ad affrontare ora significano che è come se stessimo danzando costantemente sulla sabbia in movimento: tutto cambia, cambia ogni mese, persino ogni settimana! E, come comunità di persone per le quali la danza, le arti dello spettacolo e le arti sono importanti, penso davvero che dobbiamo consapevolmente aiutarci l’un l’altro, trovando il modo di gestire questa sabbia in movimento.
È fondamentale che cerchiamo, attraverso modi eleganti di rispetto e condivisione, di prenderci cura della danza e del mondo in cui danziamo, rispettandolo, ma allo stesso tempo non lasciandoci diventare statici e passivi. Organizziamo il movimento in modo verticale e orizzontale: rimaniamo con i piedi a terra, prendiamoci cura della terra e a livello orizzontale, allunghiamoci, raggiungiamo gli altri e le altre, diamoci supporto gli uni con le altre.
L’intera traduzione, a cura di Beatrice Bressolin, è disponibile qui. Il programma di ‘What’s Next in Restructuring the Dance Ecosystem’ è qui.
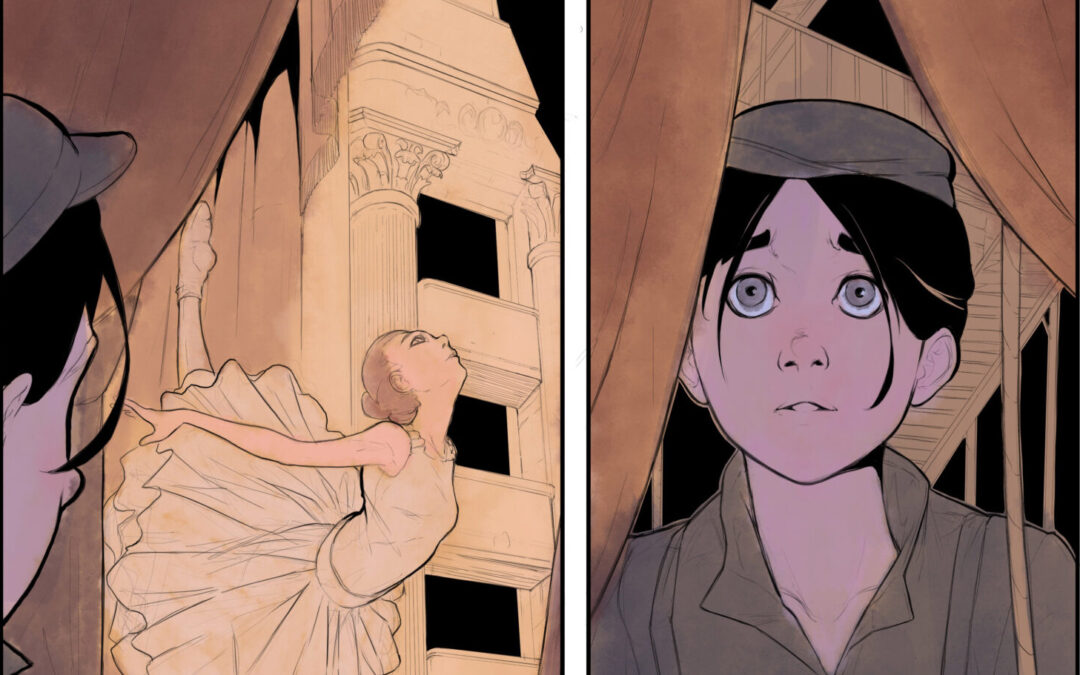
“Il Canto delle Balene è il primo lavoro che firmo in cui scelgo di sottrarmi alla scena affidando l’azione a Matteo Ramponi, performer e amico di cui ho sempre ammirato l’abilità nel diventare invisibile. Posto all’interno di una coralità lui sembra dissolversi tra i corpi diventando baricentro del movimento collettivo. Il Canto delle Balene è però anche un’opera che ha debuttato sull’orlo del precipizio. Era marzo 2020, in Italia venivano chiusi gli aeroporti. A Gent, in Belgio, noi andavamo in scena senza capire. Sentivamo arrivare con forza qualcosa a cui non eravamo in grado di dare un nome, troppo dentro alla tempesta per saper guardare. Il lavoro era stato scritto intorno ai concetti di lontananza e di richiamo, quando ancora queste parole non erano state ridefinite, ma si è trovato a debuttare nel momento esatto in cui questi termini di tingevano di tetri significati. Noi abbiamo solamente potuto rilassare i muscoli e non opporci alla tormenta. E ora, quando a distanza di mesi ci riavviciniamo a questa creatura, come possiamo parlarne?”
Chiara Bersani, performer e autrice attiva nell’ambito delle Performing Arts, del teatro di ricerca e della danza contemporanea

In occasione della residenza di Marco D’Agostin nei nostri spazi, gli abbiamo chiesto di raccontarci come si sta sviluppando il suo nuovo spettacolo, Saga, e cosa pensa dello ‘strumento residenza’.